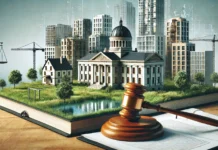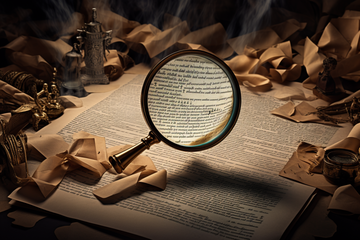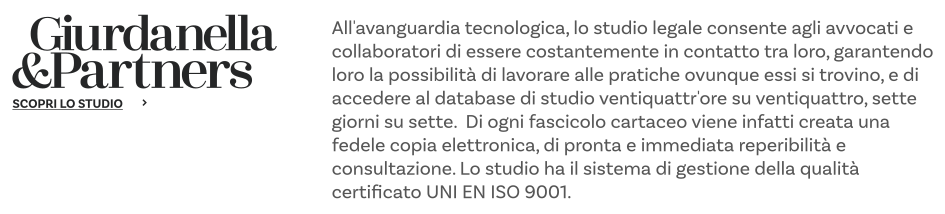Di notevole interesse la sentenza del CGA del 28 luglio 2011 sui problemi interpretativi posti dal nuovo codice del processo amministrativo e, in particolare, dall’art. 112, comma 4, laddove prescrive che il giudizio di ottemperanza si svolga nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. Si legge nella sentenza: “la previsione introdurrebbe una deroga al criterio di imputazione della competenza dettato dall’art. 113 cpa, accentrando sempre la cognizione delle domande proposte ai sensi dell’art. 30, comma 5, cpa avanti al giudice di primo grado, ossia avanti al T.A.R.. Il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato, per quel che qui rileva, può difatti sintetizzarsi nella seguente massima: “in sede di ottemperanza è ammessa la proposizione della domanda risarcitoria per i danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione che tale domanda sia introdotta avanti al T.A.R. onde scongiurare la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (…) Sussistono, invero, plurimi e convergenti elementi, di ordine letterale e sistematico, che depongono nel senso della competenza inderogabile, sia territoriale sia funzionale, del T.A.R. (…) alla cognizione della domanda risarcitoria proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 4, e 30, comma 5, cpa.” Oltre agli argomenti di carattere letterale e sistematico, spiegati analiticamente in sentenza, depone in tal senso una lettura costituzionalmente orientata della norma che la veda rispettosa del principio del doppio grado di giurisdizione, posto a presidio del corretto esercizio del diritto di difesa. Data la natura vincolante (sia per il Legislatore sia per il giudice) di tale principio, qualora il Consiglio di Stato o il CGA siano investiti di una domanda del tutto nuova, quale quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da attività amministrativa originariamente illegittima, “si impone una traslazione del giudizio al primo grado, affinché ivi si svolga il processo nelle forme, nei modi e nei termini ordinariamente stabiliti.”
Di seguito, il testo della sentenza.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza n.525 del 2011
(presidente Caracciolo, estensore Carlotti)
sul ricorso in appello n. 1366 del 2010 proposto dalla
ROCHE DIAGNOSTICS s.p.a., società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Bazzani, Jacopo Recla e Ignazio Scardina, elettivamente domiciliata in Palermo, via Rodi, n. 1, presso il secondo difensore;
c o n t r o
l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 DI RAGUSA (ora AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Giurdanella, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio dell’avv. Rosaria Zammataro;
e nei confronti
della DADE BEHRING s.p.a. (ora SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l’ottemperanza della decisione di questo Consiglio n. 695 del 23 luglio 2008; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa (d’ora in poi: “Asp” o “Azienda”); Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il consigliere Gabriele Carlotti; Uditi nella pubblica udienza del 19 maggio 2011 l’avv. M.A. Bazzani per la società appellante e l’avv. R. Zammataro, su delega dell’avv. C. Giurdanella per l’A.S.P. appellata; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O e D I R I T T O
1. – Con il ricorso emarginato la Roche Diagnostics s.p.a. – società unipersonale (nel prosieguo: “Roche”) ha richiesto l’esecuzione della decisione indicata nelle premesse e ha altresì proposto, nei confronti dell’Asp, un’azione di condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 112, comma 4, del codice del processo amministrativo (“cpa”). 2. – Si è costituita, per resistere all’impugnazione, l’Asp eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso avversario e, comunque, contestando nel merito la pretesa risarcitoria. 3. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. 4. – Per la migliore intelligenza delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio, occorre dedicare brevi cenni alla vicenda sulla quale si è innestata la controversia. A tali fini è sufficiente riferire che con la decisione posta in esecuzione questo Consiglio accolse l’appello proposto dalla Roche contro la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (sez. III), n. 554 del 9 marzo 2004. Più in particolare, va ricordato che: – la Asp (all’epoca ancora “A.s.l. n. 7 di Ragusa”) indisse una procedura pubblica per l’aggiudicazione di una fornitura di materiali necessari per analisi cliniche e service di laboratorio; – la Roche, seconda classificata, contestò in sede giurisdizionale l’ammissione alla gara della Dade Behring, aggiudicataria, per insufficienza della relativa offerta; – il T.A.R. respinse il ricorso; – il C.G.A., dopo aver disposto una verificazione sull’offerta della Dade Behring, ne accertò l’incongruità e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accolse il primitivo ricorso della Roche; – a seguito del passaggio in giudicato di detta pronuncia, dal contenuto esclusivamente annullatorio, la Roche ne ha chiesto l’ottemperanza, stante la perdurante inadempienza della Asp. Di qui l’instaurarsi del presente giudizio. 5. – Muovendo dalla premessa che, qualora l’Asp avesse correttamente escluso la Dade Behring, sarebbe risultata aggiudicataria del lotto di forniture esitato, la Roche ha domandato: a) in via principale, la condanna dell’amministrazione sanitaria al risarcimento in forma specifica, attraverso l’aggiudicazione, in favore della ricorrente, della fornitura in contestazione, previa stipula del relativo contratto per l’intera durata stabilita dal bando e per gli eventuali ulteriori periodi svolti in rinnovazione; b) in via subordinata, nel caso dell’impossibilità di ottenere in tutto o in parte il risarcimento in forma specifica, la condanna della Asp al risarcimento dei danni per equivalente. 6. – Va prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Asp. In dettaglio, l’Azienda ha, tra l’altro, osservato che: – la sentenza della quale la Roche ha chiesto l’esecuzione si è limitata a statuire sul punto dell’illegittimità degli atti di gara per omessa esclusione della aggiudicataria, senza tuttavia stabilire, in capo all’amministrazione, alcun conseguente obbligo di risarcimento dell’eventuale danno subito dalla ricorrente; – le azioni risarcitorie proposte dalla Roche devono dunque qualificarsi come formulate ai sensi dell’art. 112, comma 4, cpa; – però le suddette domande devono reputarsi inammissibili in quanto proposte per la prima volta direttamente avanti al giudice di appello, in violazione del doppio grado di giurisdizione; – invero la giurisprudenza amministrativa più recente (si cita Cons.St. sez. V, n. 2031 del 1° aprile 2011) ha interpretato l’art. 112, comma 4, cpa nel senso che la disposizione ha sì innovativamente ammesso la possibilità di proporre, direttamente e per la prima volta, in sede di ottemperanza l’azione di risarcimento per il ristoro di danni differenti da quelli derivanti dalla mancata esecuzione o dalla violazione e dall’elusione del giudicato, ma ciò ha previsto a condizione che la relativa domanda sia indirizzata al T.A.R., onde scongiurare la lesione del principio del doppio grado di giurisdizione. 7. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Azienda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. È necessario prendere le mosse dai commi 3 e 4 dell’art. 112 cpa i quali, rispettivamente, recitano: “3. Può essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato. 4. Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’ articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.”. Il comma 3 della disposizione manifestamente recepisce l’indirizzo giurisprudenziale, a dire il vero non sempre univoco, formatosi in costanza del precedente regime processuale (si vedano, tra le molte, Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2007, n. 4755; id., sez. V, 21 giugno 2006, n. 3690; id., sez. V, 28 febbraio 2006, n. 861; id., sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1080), secondo cui l’azione di condanna, inclusa quella risarcitoria, può essere proposta per la prima volta anche in sede di ottemperanza e, quindi, davanti al giudice competente per l’esecuzione, sia esso di primo o di secondo grado, ma limitatamente al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza posta in executivis o per i danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato o dalla sua violazione o elusione. Il comma 4 invece è una disposizione molto innovativa. Con essa, difatti, il Legislatore delegato, superando il precedente, negativo indirizzo pretorio maggioritario (tra le molte, Cons. St., sez. V, 27 aprile 2006, n. 2374), ha sensibilmente ampliato l’ambito delle azioni risarcitorie proponibili in sede di ottemperanza, estendendolo fino a ricomprendere le connesse domande di cui all’art. 30, comma 5, dello stesso codice, ossia le domande risarcitorie formulate dopo la proposizione di un’originaria azione di annullamento oppure in pendenza del relativo giudizio cassatorio o dopo 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Il tenore precettivo del comma 4 dell’art. 112 cpa non è tuttavia di immediata percezione, presentandosi di critica definizione sia il concetto normativo di “connessione” tra azione di ottemperanza e domanda risarcitoria sia il senso del secondo e ultimo periodo della disposizione, laddove è previsto che il giudizio di ottemperanza, nei casi in cui sia stata proposta una domanda a norma dell’art. 30, comma 5, cpa, si svolga “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”. 8. – Questo Consiglio ha già affrontato, nella sentenza n. 393 del 19 maggio 2011, il problema ermeneutico relativo al primo profilo controverso, cioè quello relativo alla nozione di connessione rilevante per l’applicazione dell’art. 112, comma 4, cpa. Al riguardo, il Consiglio, in ordine alla domanda di condanna “connessa” con quella per l’ottemperanza, prevista dall’art. 112, comma 4, cpa, ha statuito che: “tale connessione deve essere assunta come concreta e non “in astratto”, al di fuori di quanto effettivamente prospettato e richiesto con la domanda introduttiva. La domanda risarcitoria è infatti sempre e comunque “connessa” (sul piano sostanziale del concatenarsi delle vicende dell’atto illegittimo e della sua lesività) ad un accertamento di illegittimità di un atto operante nella sfera del diritto pubblico. Ma tale relazione tra illegittimità e questione aquiliana si pone in termini di conseguenzialità (della seconda), non necessariamente rilevante in termini di cumulo di domande all’interno del medesimo giudizio di ottemperanza. Per contro, l’art. 112, comma 4 citato, fa senza dubbio riferimento ad una “connessione” che non opera solo sul piano dell’astratta “causa petendi” propria del giudizio di merito “presupposto”, ma proprio sulla riconoscibilità ed attuale pendenza di una domanda “principale” tesa alla “ottemperanza”, autonomamente idonea ad instaurare il giudizio di esecuzione; deve cioè riscontrarsi la simultanea domanda, corredata da un interesse concreto ed attuale, avente ad oggetto una “ottemperanza”, cioè l’espletamento di una fase dell’azione amministrativa strettamente dipendente dalle statuizioni del giudicato (che ne predica la doverosità per l’Amministrazione intimata). In assenza di una tale domanda, espressamente prospettata ed effettivamente ammissibile, non opera la concreta connessione che consente di introdurre la pretesa risarcitoria all’interno del rito “speciale” di cui all’art. 112 medesimo. A prescindere dunque da ogni più approfondita considerazione della specifica regolamentazione processuale che la connessione comporterebbe, anche sotto il profilo della compatibilità della previsione normativa con il principio del doppio grado di giurisdizione, la domanda risarcitoria proposta, in quanto priva del rapporto di connessione necessario, deve considerarsi in questa fase inammissibile. Essa va pertanto proposta in primo grado al TAR, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.”. 9. – Una volta osservato che, nella fattispecie, sussiste il rapporto di connessione siccome individuato applicando i criteri declinati da questo Consiglio nella pronuncia sopra riferita, rimane allora da precisare l’esatto significato del comma 4 dell’art. 112 cpa nella parte in cui la norma prescrive che il giudizio di ottemperanza si svolga nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. Sul piano teorico si impone, quindi, al Collegio il compito di completare l’esegesi dell’art. 112, comma 4, cpa affrontando la questione che la sentenza n. 393/2011 ha riservato a successivi approfondimenti, cioè il problema della “compatibilità della previsione normativa con il principio del doppio grado di giurisdizione”. Ed invero, il predetto comma 4 si presta a due differenti letture con riferimento all’esatta individuazione del giudice competente sulla domanda risarcitoria. Secondo un primo approccio potrebbe ritenersi che la competenza a conoscere della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 112, comma 4, cpa spetti allo stesso giudice dell’ottemperanza, da selezionarsi in base ai criteri dettati dal successivo art. 113 cpa in combinato disposto con l’art. 112, comma 2, cpa; quindi, nel caso di specie, al C.G.A., essendo quest’ultimo l’organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza, passata in giudicato, della cui ottemperanza si tratta. Ponendosi nella scia di tali coordinate esegetiche al comma 4 dovrebbe allora riconoscersi un significato precettivo minimale consistente nella regola secondo la quale il giudice dell’ottemperanza, per la trattazione della domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, cpa, sia tenuto a seguire il rito ordinario dell’udienza pubblica invece di quello in camera di consiglio, normalmente previsto per il giudizio di ottemperanza (così l’art. 87, comma 2, lett. d), cpa). In base a una diversa interpretazione, oggi recepita dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata dalla Asp e in un’altra della Sezione terza (Cons. St. sez. V, n. 2031 del 1° aprile 2011; Cons. St., sez. III, 5 maggio 2011, n. 2693), l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 112 cpa avrebbe ben altro valore: in particolare, la previsione introdurrebbe una deroga al criterio di imputazione della competenza dettato dall’art. 113 cpa, accentrando sempre la cognizione delle domande proposte ai sensi dell’art. 30, comma 5, cpa avanti al giudice di primo grado, ossia avanti al T.A.R.. Il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato, per quel che qui rileva, può difatti sintetizzarsi nella seguente massima: “in sede di ottemperanza è ammessa la proposizione della domanda risarcitoria per i danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione che tale domanda sia introdotta avanti al T.A.R. onde scongiurare la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione”. L’opzione per l’una o l’altra tesi non è evidentemente priva di conseguenze dal momento che, qualora si aderisse alla seconda ricostruzione, il Consiglio di Stato e ancor più questo Consiglio (in forza della previsione speciale contenuta nell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 373/2003) sarebbero tenuti ad accogliere o a rilevare d’ufficio le eccezioni di incompetenza funzionale inderogabile ai sensi dell’art. 14, comma 3, cpa. 10. – Sul punto il Collegio ritiene di doversi allineare all’orientamento, sopra citato, recentemente assunto dal Consiglio di Stato. Sussistono, invero, plurimi e convergenti elementi, di ordine letterale e sistematico, che depongono nel senso della competenza inderogabile, sia territoriale sia funzionale, del T.A.R. (nella specie, di quello per la Sicilia), alla cognizione della domanda risarcitoria proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 4, e 30, comma 5, cpa. Il primo elemento è di carattere letterale e si incentra sulla considerazione della specifica formulazione dell’ultimo periodo del succitato comma 4, laddove è scritto che: “In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”. Siffatta dizione evoca quella contenuta nel successivo art. 117, comma 6, cpa in materia di ricorsi avverso il silenzio secondo cui: “Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.”. Si è appena rilevato che il comma 4 dell’art. 112 cpa evoca la previsione del successivo art. 117, nondimeno la formulazione delle due disposizioni – al di là del riferimento, nella seconda norma, alla sola azione di risarcimento per il danno da ritardo (riferimento che, nell’economia di quanto si va ad esporre non è determinante) – non è esattamente identica. Più in dettaglio, il comma 6 dell’art. 117 prevede un potere (“può”), il cui esercizio è rimesso alla prudente valutazione discrezionale del giudicante, di separare le forme della trattazione delle due domande, introdotte congiuntamente dal ricorrente, mentre il comma 4 dell’art. 112 usa il verbo “svolgersi” all’indicativo presente, sottintendendo l’obbligatorietà, per il giudicante, di applicare le forme, i modi e i termini del processo ordinario. Ancora, il comma 6 dell’art. 117 cpa utilizza il vocabolo “rito”, mentre nel comma 4 dell’art. 112 cpa si trova la parola “processo”. Il Collegio ritiene che tali difformità lessicali non siano casuali né prive di significato e che, anzi, esse meritino di essere valorizzate ai fini interpretativi, concorrendo le stesse a illuminare la differente ratio che ispira le due previsioni, soprattutto se collocate sullo sfondo della trama dei principi che reggono l’intero disegno del processo amministrativo delineato dal Legislatore delegato nel nuovo codice del processo amministrativo. Deve invero presumersi, alla stregua dei normali criteri ermeneutici preordinati alla ricostruzione della voluntas legis, che i conditores iuris abbiano intenzionalmente diversificato le formulazioni dei due articoli, tanto più che gli stessi si trovano inseriti topograficamente, a poca distanza, e nello stesso Libro (il Quarto) dedicato congiuntamente all’ottemperanza e ai riti speciali. Ebbene, muovendo da tali premesse e coniugando l’analisi letterale con quella sistematica, è opinione del Collegio che le sopra indicate differenze lessicali trovino idonea giustificazione teorica e coerente spiegazione razionale nella necessità di operare un’identica allocazione, in primo grado, della cognizione della domanda risarcitoria sia nel caso del giudizio sul silenzio e sia in quello del giudizio di ottemperanza, quand’anche quest’ultimo, a norma dell’art. 113 cpa, sarebbe da introdurre avanti al giudice di secondo grado. In altri termini, è opinione del Collegio che l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 112 cpa, nonostante la sua non piana formulazione, contenga una deroga al successivo art. 113. Non v’è dubbio, del resto, che il concetto di “rito” non sia sovrapponibile a quello di “processo”. La prima nozione difatti presuppone la seconda e riguarda le modalità di trattazione della domanda veicolata da uno o più ricorsi; il “processo” per contro è concetto più intimamente connesso a quello di “giudizio” e, in particolare, individua l’insieme degli atti che, nel medesimo grado, coprono l’intera sequenza dell’instaurazione, dello svolgimento e della conclusione di un rapporto processuale venuto ad esistenza a seguito dell’esercizio di una o più azioni. Il giudizio pertanto inizia con la proposizione del ricorso introduttivo avanti al T.A.R. e si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza, di primo o di secondo grado, che definisce la controversia. Il giudizio amministrativo, inoltre, può articolarsi in due gradi (fatta salva l’eventuale cognizione della Corte di cassazione che, tuttavia, concerne la valutazione della corretta selezione del giudice provvisto di iuris dictio e, quindi, a ben vedere si colloca al di fuori del giudizio amministrativo). In ciascun grado si svolge un diverso processo. Nell’ambito di ciascun processo possono o debbono seguirsi differenti riti. Siffatta ricostruzione trova precisi addentellati positivi nella sistematica codicistica. Solo per citarne alcuni, deve richiamarsi l’art. 32 cpa che disciplina il cumulo di azioni introdotte nell’ambito del medesimo giudizio e nel quale sono stabilite le regole di selezione dei diversi riti; ancora è inequivoca nella prospettiva sopra tratteggiata l’intitolazione del Libro II del codice, dedicato, per l’appunto, al “processo amministrativo di primo grado”. Il dato letterale tuttavia, seppur pregno di conferme, non è però l’unico elemento che conforta la sopra esposta interpretazione comparata degli artt. 112, comma 4, e 113 cpa. Determinante è invece la considerazione del principio del doppio grado di giurisdizione, ricavabile da plurime disposizioni del codice (tra le quali, si citano l’art. 6, comma 1, e gli art. 91 ss. cpa). Ebbene, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 30, comma 5, cpa, qualora introdotta per la prima volta in sede di ottemperanza (e non “nel corso del giudizio” di primo grado, come pure consente la disposizione), è a tutti gli effetti una domanda nuova, seppure connessa a quella annullatoria (già definita), e come tale deve essere assistita da tutte le garanzie, stabilite dalle norme di rango primario e costituzionale, che presidiano il corretto esercizio del diritto di difesa. Tra queste garanzie un ruolo fondamentale va riconosciuto, ovviamente, al principio del doppio grado che deve sempre orientare il giudicante nell’applicazione delle regole del codice. Al riguardo, icasticamente può affermarsi che, fatti salvi i casi di espresse deroghe legislative al canone fondamentale del doppio grado di giurisdizione (sui quali subito infra), il giudice, nell’applicare qualunque norma processuale che si presti a differenti letture, deve sempre optare per l’esegesi costituzionalmente orientata e, dunque, con riferimento al problema qui esaminato, il giudice deve sempre optare per l’interpretazione rispettosa del principio del doppio grado di giurisdizione. Vero è che esistono ipotesi in cui detto principio non è osservato e un caso emblematico è proprio l’art. 112, comma 3, cpa, qualora il Consiglio di Stato sia competente a decidere della domanda di risarcimento dei danni ivi contemplata. Nondimeno, a ben riflettere, tali deroghe non prestano il fianco a serie perplessità di ordine costituzionale. Le due fattispecie menzionate dal sunnominato art. 112, comma 3, cpa, difatti, quand’anche trattate in unico grado avanti al solo giudice di appello (Consiglio di Stato o Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) o concernono la cognizione della spettanza di accessori a un diritto di credito della parte vittoriosa, diritto già cristallizzato in una pronuncia giurisdizionale provvista di una piena (sentenza passata in giudicato) o di un’elevata stabilità (sentenza di secondo grado esecutiva), oppure riguardano questioni strettamente correlate all’obbligo di attuazione di un comando giurisdizionale rimasto ineseguito, ma nitidamente definito nella decisione posta in executivis. Detto altrimenti, la deroga al principio del doppio grado di giurisdizione contenuta nell’art. 112, comma 3, cpa investe ambiti ristrettissimi di cognizione, in relazione ai quali il canone del doppio grado si presenta recessivo rispetto all’altrettanto cogente principio della ragionevole durata del processo. In questa prospettiva, ma solo in questa prospettiva, stante l’assenza di un’inderogabilità assoluta del principio del doppio grado di giurisdizione (v. Corte cost. nn. 41 del 1965, 22 e 117 del 1973, 186 del 1980, 78 del 1984 e 80 del 1988 e ord. n. 395 del 1988), il Legislatore ha ritenuto ragionevolmente accettabile il sacrificio di un pieno dispiegarsi del diritto di difesa. Gli enunciati principi spiegano allora il diverso disposto del comma 4 dell’art. 112 e del comma 6 dell’art. 117 cpa. Nel secondo caso (art. 117, comma 6) il processo, avente ad oggetto anche la domanda di risarcimento, pende avanti al giudice di primo grado e, pertanto, si pone soltanto un problema di eventuale differenziazione di riti, problema la cui soluzione il Legislatore delegato ha affidato alla scelta del giudicante. Nella prima ipotesi (art. 112, comma 4), invece, il Consiglio di Stato o il CGA vengono investiti di una domanda del tutto nuova, in relazione alla quale, attesa la natura vincolante (sia per il Legislatore sia per il giudice) del principio del doppio grado di giurisdizione, si impone una traslazione del giudizio al primo grado, affinché ivi si svolga il processo nelle forme, nei modi e nei termini ordinariamente stabiliti. In conclusione, applicando le sopra delineate coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta sottoposta allo scrutinio del Collegio, deve ritenersi che il ricorso proposto dalla Roche sia inammissibile per violazione della competenza funzionale e territoriale inderogabile del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania. 11. – Non conduce a differenti conclusioni la circostanza che l’azione risarcitoria introdotta dalla ricorrente sia stata qualificata nei termini di un’azione risarcitoria reintegratoria in forma specifica e, soltanto in via subordinata (ossia nell’ipotesi dell’impossibilità di ottenere in via giurisdizionale l’aggiudicazione della gara), per equivalente. In realtà, il tenore del comma 4 dell’art. 112 cpa non giustifica letture differenziate a seconda delle concrete richieste di parte. La disposizione infatti accenna genericamente alla “domanda risarcitoria” e, quindi, sia al risarcimento in forma specifica sia a quello per equivalente che non costituiscono domande differenziate, ma unicamente differenti tecniche, connotate da un diverso grado di satisfattività, di realizzazione dell’unica pretesa del ricorrente. Ciò è eloquentemente testimoniato dal secondo comma dell’art. 2058 c.c., ove si prevede che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente qualora quello in forma specifica risulti eccessivamente oneroso per il debitore, sottintendendo così una sorta di fungibilità tra le due richieste. In questi termini è d’altronde l’orientamento prevalente in dottrina, secondo cui la reintegrazione in forma specifica appartiene al medesimo genere del risarcimento del danno, di cui costituisce una forma al pari del risarcimento per equivalente. Nemmeno si discosta da tale quadro di principi la giurisprudenza civile, atteso che nelle pronunce dei giudici ordinari si trova affermato che l’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della reintegrazione in forma specifica, non vìola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, ma la relativa richiesta deve reputarsi implicata nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica (Cass. n. 4925/2006; id., n. 15021/2005); ancora la Corte di cassazione ha affermato che la richiesta di condanna per equivalente pecuniario formulata in sede di precisazione delle conclusioni non integra una mutatio libelli, semmai una consentita emendatio rispetto alla domanda alternativa formulata con l’atto di citazione, non risultando mutato né il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa (causa petendi), né l’originario petitum (Cass. n. 1700/2009; id., n. 5103/1995). Dalla inammissibilità della domanda discende allora che il Collegio non è tenuto a verificare se la fornitura della quale si controverte sia stata in tutto o in parte eseguita, appartenendo il relativo accertamento alla cognizione del diverso giudice che sarà investito della controversia. 12. – Infine, alla luce di tutto quanto premesso, nemmeno spetta al Collegio provvedere sull’istanza, avanzata dalla Roche, di rimessione in termini per errore scusabile ai fini della riproposizione nella sede giurisdizionale competente della domanda risarcitoria: sulla scorta delle precedenti argomentazioni, si osserva che la richiesta, ove riproposta in primo grado, dovrà essere scrutinata dal T.A.R., che certamente non mancherà di tener conto delle inevitabili incertezze che hanno accompagnato le prime applicazioni del codice del processo amministrativo. 13. – Alla stregua dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione; in particolare, deve intendersi superata (nel senso della mancanza dei presupposti) la richiesta, avanzata dalla Roche, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, comma 4, cpa. 14. – In ragione della novità delle questioni trattate, si ravvisano, in via eccezionale, ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 28 luglio 2011