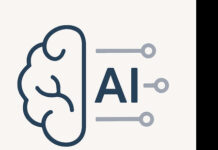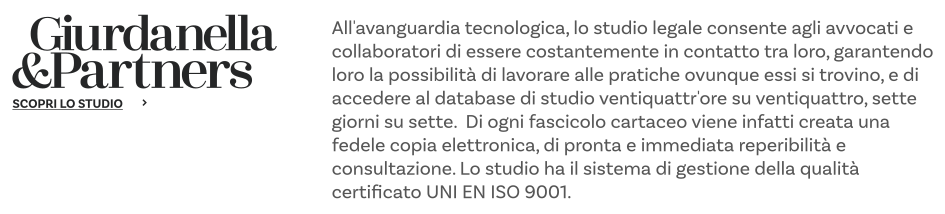Alan Turing, come sappiamo, era idealmente più vicino ai giorni nostri che al periodo immediatamente successivo alla sua vita.
Nei settant’anni che hanno seguito la pubblicazione del suo articolo “Computer machinery and intelligence” del 1950, gli sviluppi dell’intelligenza artificiale rimanevano di dominio del mondo accademico e, pur sviluppandosi, non confluivano in qualcosa che cambiasse concretamente la realtà e la società. Oggi invece sembra che lo scenario sia differente: con l’ingresso nelle nostre vite dei Large Language Model, in questi anni Venti, ci stiamo probabilmente approssimando a qualcosa che inizia a concretizzare le idee da lui enucleate.
Possiamo affermare che, dopo più di mezzo secolo in cui la storia dell’intelligenza artificiale è stata un alternarsi di inverni e primavere molto instabili (cioè fasi di stasi e di entusiasmi di breve durata), ora stiamo probabilmente entrando in un optimum climatico tecnologico più stabile.
Un modo per capire se abbiamo davvero fatto ingresso in questa nuova fase di “passaggio alla realtà” dell’intelligenza artificiale, è proprio il test di Turing. Non però nel senso in cui siamo abituati a pensarlo.
Probabilmente, se chiedessi a ciascuno dei lettori di questo articolo: “Quante volte hai effettuato nella tua vita un test di Turing?” è verosimile che la risposta di molte persone sarebbe “Mai”. In effetti, probabilmente, nessuno degli individui che stanno leggendo questo testo (e neanche chi lo ha scritto) si è mai trovato a svolgere un esperimento controllato in una stanza con un PC di fronte a una parete oltre la quale fossero presenti un altro essere umano e un’intelligenza artificiale, con il compito di interrogare l’uno e l’altra senza sapere da chi provenissero le risposte. Test simili sono svolti periodicamente da alcune istituzioni (per esempio dalla Royal Society di Londra), ma riguardano comunità di studiosi ristrette e anche, a modo loro, un po’ “iniziatiche”, distanti dalla nostra quotidianità.
In realtà, però, è sufficiente cambiare ottica per rispondere in modo completamente diverso alla domanda, giungendo a sostenere che ciascuno di noi effettua molti test di Turing nelle sue giornate, e che il “gioco dell’imitazione” forse fa parte della nostra routine più di quanto percepiamo.
Questo, infatti, è ciò che accade se pensiamo ai “test di Turing” integrati nella nostra vita abituale, ovvero a tutte le volte che ci troviamo di fronte al dilemma di non comprendere se un soggetto o un’entità con cui interagiamo attraverso il diaframma del web, sia un essere umano o un algoritmo.
Da questo punto di vista, il test di Turing è parte della nostra vita in modo talmente silenzioso che non ci facciamo caso.
Certo, questo non avviene ogni volta che interloquiamo con un sistema informatico. Penso (e spero) che nessuno quando “parla” con Siri o con Alexa abbia il dubbio che dietro le risposte possa esserci un umano, e anche con i Large Language Model più avanzati, di regola, abbiamo la piena percezione di avere a che fare con una macchina (anche perché ChatGPT e Gemini hanno stili narrativi effettivamente molto riconoscibili).
Però i casi che generano il dubbio esistono, e sono più numerosi di quanto percepiamo. Pensiamo a quando, di fronte alla chat asettica di un servizio clienti, ci domandiamo se dall’altra parte ci sia una raffinata chatbot oppure un interlocutore umano che ha ricevuto istruzioni per fornire risposte impersonali e standardizzate. Oppure, pensiamo a quando il sistema di moderazione di un social network rimuove un nostro commento, magari ingiustamente, decontestualizzandolo: il nostro primo dubbio è se quel responso sia pervenuto da un moderatore umano, magari troppo sovraccaricato di lavoro, oppure da un sistema di machine learning non troppo avanzato.
Questi sono alcuni esempi di come il test di Turing forse non debba più essere pensato come un esperimento da laboratorio, ma come qualcosa con cui tutti abbiamo familiarità, ed è questo – al di là dell’esito di ciascuna “prova” – uno dei più chiari segnali che siamo entrati in una fase storica in cui l’immaginario di Alan Turing inizia a trovare riscontro nella realtà.
Una conseguenza interessante di tutto ciò è che anche la legge sta iniziando ad occuparsi di questa questione, allo scopo di proteggere le persone dai test di Turing involontari della vita quotidiana, facendo in modo che si riduca o si neutralizzi il dubbio sulla natura umana o algoritmica dei soggetti con cui interagiamo via web.
L’Artificial Intelligence Act del 2024 dell’Unione Europea contiene una disposizione molto significativa da questo punto di vista, che potremmo denominare “norma anti test di Turing”.
Si trova al primo comma dell’articolo 50, e appare talmente chiara da non richiedere parafrasi: “I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA”.
È importante osservare che questa disposizione non riguarda “i prodotti” dell’intelligenza artificiale, bensì attiene al momento diretto del confronto uomo-macchina: l’utente deve conoscere in tempo reale se durante un’interazione sta interloquendo con un homo sapiens o con un’intelligenza artificiale. Quindi è una norma abbastanza stringente: per esempio obbliga a una chiarezza totale i fornitori di servizi che utilizzano chatbot (come nei customer care delle aziende online), o le piattaforme web che adoperano sistemi di moderazione algoritmica.
In verità, potrebbe essere anche una norma un po’ eccessiva, perché in fondo, abituarci a svolgere test di Turing quotidiani, e a riconoscere autonomamente l’uomo dalla macchina, potrebbe aiutarci a tenere allenata la mente e a navigare nel web con maggiore spirito critico. Ma in verità la norma non esclude questa possibilità, infatti nel passaggio immediatamente successivo stabilisce che l’obbligo di segnalare la natura non-umana dell’interlocutore vale “a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo”.
Insomma, i test di Turing quotidiani non scompariranno del tutto, e non dobbiamo prenderlo come un qualcosa di negativo, anzi: forse, proprio Alan Turing avrebbe letto con sollievo una norma che tiene in vita la possibilità che il gioco dell’imitazione sia parte delle giornate di tutti noi.